In molti si sono domandati per quale ragione il diritto sia nato a Roma e non in Grecia. Può sembrare strano infatti che i greci – nonostante le alte vette raggiunte in altri campi come l’arte e la filosofia – non abbiano sviluppato per primi una scienza giuridica.
Ovviamente anche in Grecia vi erano delle leggi, come in ogni civiltà umana, mancava però un metodo, una scienza del diritto. Quella nacque solo a Roma. Il greco antico non conobbe alcuna parola per indicare il diritto o il giurista, una figura quest’ultima che di fatto non esisteva. Già, perché in Grecia c’erano filosofi, architetti, scultori, storici, medici ma non giuristi.
Sorge spontaneo chiedersi il motivo di questo vuoto nel mondo greco e quali condizioni resero invece possibile il decollo di una scienza giuridica a Roma. Il professor Emanuele Stolfi – nella sua “Introduzione allo studio dei diritti greci” (Giappiccheli, Torino, 2006) – fornisce una possibile spiegazione, che a suo parere va cercata nel diverso modo che i greci e i romani avevano di concepire il proprio rapporto con la divinità.
“Chi confronti i profili più risalenti dell’esperienza religiosa greca e romana coglie alcuni elementi distintivi di estremo interesse […]. In Grecia incontriamo una percezione del sacro che si lega a una formidabile inventiva mitologica e cosmogonica, che continuamente si alimenta di rivisitazioni, accumulazioni e connessioni, attingendo a fasi remote della propria storia e, al contempo, a strati sempre più profondi dell’interiorità umana, disseppellendo angosce e pulsioni: ma al fine di esorcizzarle nella conoscenza, non per gestirle o prevenirle tramite una rete di comportamenti prescritti e di atti rituali. Del resto, l’osservanza di questi ultimi non sarebbe mai in grado, da sola, di garantire il compiersi dell’effetto sperato: per quanto sia scrupolosa l’attenzione rivolta alla rivelazione del dio, nessun uomo potrà essere certo di non compiere ingiustizie, e correrà sempre il rischio di macchiarsi dei misfatti più atroci. Il caso di Edipo è emblematico: per sfuggire al compimento dell’oracolo di Delfi egli evita di tornare a Corinto, ma è proprio per scongiurare ogni rapporto con quelli che crede i suoi veri genitori, che in realtà egli si fa strumento del proprio destino, e si avvia verso l’uccisione del padre e le nozze incestuose con la madre[…].
Nessuna osservanza dei precetti divini e nessun compimento di gesti rituali può tenere indenne l’individuo dalla sciagura, se in tal senso spinge il destino, la volontà degli dei o gli atroci, oscuri meccanismi che a distanza di generazioni danno cadere sui figli o i nipoti le colpe dei padri e dei nonni […].
Il rapporto dei romani con le proprie divinità è non meno angoscioso: si tratta però di una forma di angoscia diversa. L’uomo romano arcaico non ha in pratica piena libertà in alcun suo gesto socialmente rilevante: perché esso vada a buon fine, ne scaturisca “magicamente” l’effetto voluto e non si susciti l’ira di un dio, occorre rispettare una procedura determinata, fissa e invariabile, stilizzazione di un comportamento che sia gradito alle divinità e si quindi formalizzando in rito. E’ quest’ultimo, dunque, l’elemento determinante nel vissuto della città in età monarchica e protorepubblicana: la stretta osservanza del rito garantisce stabilità e protezione altrimenti irreperibili, e a prassi rituali ci si affida per accostarsi alla divnità, ma anche per dichiarare la guerra, per trasferire la proprietà, per contrarre un matrimonio e persino per raccogliere le messi senza che si adirino le relative divinità.
Contrapporre mito greco e rito romano ha forse qualcosa di semplicistico, ma ci conduce – mi sembra – nella direzione giusta. E dietro quei due diversi stili di religiosità, non è difficile riconoscere i prodromi delle successive forme di razionalità laica a cui si darà vita da una parte e dall’altra: nel mondo greco, un impianto speculativo di grande profondità, che si costituisce come amore della conoscenza (philosophìa appunto) e ricerca del vero; a Roma, una tecnica che non mira al puro sapere né allo scavo nell’interiorità umana, ma a un disciplinamento minuzioso dei comportamenti sociali, che non porta mera conoscenza ma ordine pubblico e stabilità, anche nelle condotte che il potere politico non può soffermarsi a regolare”.







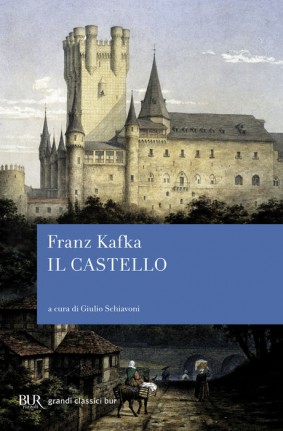 Un romanzo incompiuto, che nega al lettore di capire a pieno la fitta simbologia che lo domina, un libro chiaramente metaforico ma quasi impossibile da interpretare: questo è il Castello di Kafka.
Un romanzo incompiuto, che nega al lettore di capire a pieno la fitta simbologia che lo domina, un libro chiaramente metaforico ma quasi impossibile da interpretare: questo è il Castello di Kafka. Il Castello è inarrivabile. Il Castello vede e domina tutto dall’alto. E’ evidente che se potesse K. lo salirebbe, ma non gli è concesso, è impensabile una cosa del genere. Qui si può partire con le intepretazioni. Il Castello è forse l’Infinito, l’Assoluto, Dio? Difficile da credere, perchè in comune con queste entità ha solo la caratteristica di non essere raggiungibile, con la naturale solennità che ne consegue. Il Castello è pensabile ma non conoscibile, come il noumeno di Kant. Ma probabilmente cercare somiglianze tra il Castello e idee di matrice filosofica o religiosa non ci conduce sulla strada giusta.
Il Castello è inarrivabile. Il Castello vede e domina tutto dall’alto. E’ evidente che se potesse K. lo salirebbe, ma non gli è concesso, è impensabile una cosa del genere. Qui si può partire con le intepretazioni. Il Castello è forse l’Infinito, l’Assoluto, Dio? Difficile da credere, perchè in comune con queste entità ha solo la caratteristica di non essere raggiungibile, con la naturale solennità che ne consegue. Il Castello è pensabile ma non conoscibile, come il noumeno di Kant. Ma probabilmente cercare somiglianze tra il Castello e idee di matrice filosofica o religiosa non ci conduce sulla strada giusta.